
Codice CIN: Appartamento Camilla CIN: IT006127C2H6HAXTKN; Appartamento Margherita CIN: IT006127C2RSXFX9WT; Appartamento Lodovica CIN: IT006127C2CVHRXIZB
Castello di Pasturana
Situato in uno dei panorami più suggestivi del basso Piemonte, il castello di Pasturana è una location unica che coniuga romanticismo ed eleganza, offrendo spazi interni ed esterni curati e accoglienti per un’esperienza speciale.
Posto sulle alture alle spalle di Novi Ligure domina le vallate fra Lemme, Orba e Scrivia, offrendo una vista eccezionale che, nelle giornate limpide, abbraccia Appennini, Alpi e la vasta Pianura Padana.
Varcato il cancello d’accesso troviamo un portico colonnato affiancato dalla vecchia torre del castello, parte più antica di tutta la residenza a cui si affianca a sua volta una piccola serra. Seguendo invece il viale di ghiaia si attraversano quattro giardini all’italiana delineati da siepi ed aiuole che danno accesso al bosco.
La facciata principale dell’edificio presenta tracce di un loggiato a tre archi e grandi finestroni che richiamano lo stile architettonico dei periodi di Luigi XIII e Luigi XIV. Negli angoli, quattro torrette di guardia testimoniano la sua antica funzione fortificata.
Un grande scalone ornato di putti e balaustra ed un portone baroccheggiante caratterizzano l’entrata nella corte, un ampio spazio dove troviamo l’accesso alla cappella consacrata e quello della residenza.
All’interno troviamo grandi e numerosi saloni, quartieri abitativi, ampie cucine e servizi. I saloni e salotti offrono ambienti caldi e confortevoli per ospitare eventi in tutte le stagioni.
Servizi Offerti
Apertura al pubblico
Il castello di Pasturana è aperto al pubblico ogni anno in ricorrenza di S. Anna, Santa patrona del paese. In ricorrenza il castello ospita un concerto di musica classica nella corte interna, questo evento è curato ed organizzato dalla pro-loco di Pasturana.
Ospitalità
Il castello dispone di tre appartamenti affascinanti, recentemente ristrutturati, situati al primo e al secondo piano, di cui i primi due accessibili con ascensore dedicato. Ogni appartamento è dotato di internet, aria condizionata e riscaldamento, per garantire comfort in ogni stagione dell’anno.
Appartamento Margherita (Primo Piano)
Questo accogliente appartamento presenta un soggiorno con angolo cottura, due camere matrimoniali e un bagno, perfetto per un soggiorno intimo e rilassante.
Appartamento Lodovica (Secondo Piano)
Simile nel design, l’appartamento Lodovica offre un soggiorno con angolo cottura, due camere matrimoniali e un bagno, combinando eleganza e funzionalità.
Appartamento Camilla (Piano Nobile)
L’appartamento Camilla ha un accesso dedicato tramite una scala privata ed è composto da tre camere da letto, tre bagni, una cucina, una sala da pranzo e un grande salotto.
Eventi
Il castello di Pasturana ospita eventi privati e aziendali, matrimoni religiosi e civili. La proprietà è disponibile ad assistervi nella pianificazione dell’evento, suggerendo soluzioni ideali per ogni fase ed ogni tipologia di evento.
Cenni storici
La prima notizia che attesta l’esistenza di Pasturana risale al 981. Con il nome “Pastorianum”, la località viene menzionata all’interno di un diploma imperiale emesso a favore del Monastero di San Salvatore di Pavia. Nei primi secoli, Pasturana faceva quindi parte del contado di Tortona.
Con il procedere del tempo, il piccolo borgo segue le sorti delle comunità del cosiddetto Oltregiogo e al suo dominio si alternano lo Stato di Milano, la Repubblica di Genova e il Marchesato del Monferrato. Benché oggi faccia amministrativamente parte del Piemonte, Pasturana ha sempre orbitato tra la potenza marittima ligure e il fiorente ducato lombardo, con pretese anche da parte dei Paleologi monferrini.
Pasturana è fra i numerosi feudi che l’imperatore Enrico VII (l’Arrigo che Dante Alighieri colloca nel Paradiso) concede a Opizzino Spinola del ramo di Luccoli nel 1313. Se questo evento segna una tappa fondamentale per l’antica casata genovese in termini di consolidamento della propria posizione oltre i confini della Repubblica, per Pasturana non è stato l’inizio di una maggiore stabilità, come conferma il fatto che appena una ventina di anni dopo la località e i suoi abitanti devono giurare fedeltà al Marchese Giovanni Paleologo.
Il Quattrocento e il Cinquecento: la famiglia Trotti di Alessandria
Il Quattrocento non si apre per Pasturana nel migliore dei modi. Nei primi anni del secolo, è infatti vittima dei saccheggi compiuti dalle truppe al seguito del celebre condottiero di ventura Facino Cane che, complice la crisi innescata dalla morte di Gian Galeazzo Visconti primo duca di Milano, cercava di fondare un suo stato personale. Nella sua avanzata, il capitano sottomette anche Tortona e Alessandria.
Durante il XV secolo, le sorti di Pasturana sono legate alla città oggi capoluogo di provincia. Sventato il tentativo di Facino Cane e rientrato nei possedimenti del Ducato di Milano, il 30 gennaio 1430 il borgo viene concesso tramite investitura viscontea a Franceschino de’ Trotti di Alessandria e a suo figlio Bongiovanni con diritto di successione in linea di primogenitura.
La signoria Trotti dura quasi due secoli: nel 1555 l’investitura viene rinnovata dal futuro re di Spagna Filippo II, in quel momento ancora principe, ai fratelli Alessandro e Baldassarre, proprietari rispettivamente per due terzi e un terzo. Al primo sono con ogni probabilità da ricondurre alcuni interventi sul maniero di cui non conosciamo le antiche fattezze. All’interno della dimora è infatti tutt’ora conservato un bel camino in stile rinascimentale ascrivibile alla metà del Cinquecento che reca incisa l’iscrizione “Al. T.”, ovvero le iniziali di Alessandro Trotti.
Secondo lo storico ottocentesco Goffredo Casalis, l’intero castello venne fatto edificare in questa fase, contestualmente alla parrocchia di San Martino e alla piccola chiesa dedicata alla Trinità. Allo stato attuale degli studi non è possibile avere la certezza che l’edificio non sia sorto su un’architettura preesistente, tuttavia, si può affermare che a questo periodo risale anche la torre che si incontra sulla destra non appena varcato il cancello di ingresso per le fattezze con cui si mostra. Nonostante il diritto di primogenitura, la proprietà del feudo subisce frazionamenti tra gli eredi Trotti che, originari di Alessandria, probabilmente soggiornavano solo saltuariamente nel castello di Pasturana. Per una serie di circostanze genealogiche e successorie, nel 1586 Giulio Trotti riunisce la proprietà e la trasmette al suo unico figlio maschio Antonio Maria.
Una brevissima fase Lomellini
Con Antonio Maria de’ Trotti si chiude un capitolo della storia del castello di Pasturana poiché nel 1591 chiese il permesso a Filippo II di Spagna di poter vendere il feudo ereditato dal padre Giulio al genovese Nicolosio Lomellino, accordatogli due anni dopo e seguito l’anno successivo dall’atto ci compravendita (4 febbraio 1594).
Nicolosio Lomellino fu uno dei grandi protagonisti del rinnovo architettonico nella Superba: aveva già fatto edificare alcuni decenni prima un sontuoso palazzo affacciato sulla prestigiosa Strada Nuova (attuale via Garibaldi, civico 14) che si caratterizza tutt’oggi per una facciata dall’elegante decorazione a stucco ideata dal raffinato Giovanni Battista Castello, il Bergamasco. Quattro anni dopo l’acquisto di Pasturana, Nicolosio muore e lascia agli eredi i figli Angelo e Gio.
Con una esorbitante quantità di debiti, contratti probabilmente proprio per le ingenti spese sostenute in campo immobiliare, i figli si vedono quindi costretti ad alienare la recente acquisizione paterna a Ferdinando Spinola del ramo di Tassarolo.
Gli Spinola di Tassarolo
Dal 6 luglio 1604, data dell’atto di vendita dai Lomellino agli Spinola, fino all’inizio del secolo scorso la proprietà del castello di Pasturana viene tramandata per via ereditaria all’interno della famiglia senza soluzione di continuità.
L’attuale aspetto dell’edificio – che ora ricorda più una villa suburbana che una fortificazione – è legato non tanto al primo Spinola proprietario, Ferdinando, quanto al secondo, Filippo, rispettivamente zio e nipote. Filippo (1607-1688) fu il quarto conte di Tassarolo, titolo che era stato concesso al nonno Marcantonio dall’imperatore d’Asburgo per una lunga storia di fedeltà e servizio all’impero. Nonostante il possesso del palazzo pervenne allo Spinola per via ereditaria, fu tutt’altro che semplice acquisirne i diritti feudali e solo nel 1636, sette anni dopo la morte dello zio, il conte Spinola ebbe la possibilità di dichiararsi feudatario di Pasturana. Come viene specificato in ognuno dei suoi quattro testamenti dettati nell’arco di oltre trent’anni, per riuscire a ottenere l’investitura ufficiale fu costretto a sborsare una somma talmente alta da dover vendere alcune partecipazioni che possedeva sul feudo di Borgo Fornari. Dai documenti di ultime volontà emerge chiaramente l’affezione che Filippo provava per il nuovo feudo, cui era forse più legato rispetto a quello avuto di Tassarolo.
Nel corso degli anni, si premurò infatti sia di ristrutturare l’edificio, sia di ampliarne le pertinenze con l’acquisto di terreni e boschi. L’operazione di restyling architettonico avvenne probabilmente negli anni successivi al 1636, mentre a questa data risale pressappoco la commissione al pittore genovese Gioacchino Assereto della pala d’altare della parrocchia di San Martino, sulla cui porzione inferiore è visibile una veduta del castello visto da fondovalle che testimonia il suo aspetto antecedente. Sempre a questo momento è poi riconducibile la richiesta al fiammingo Cornelis De Wael di due monumentali vedute di Tassarolo e Pasturana, ancora ricordate tra i dipinti menzionati nell’inventario redatto alla sua morte.
Filippo sviluppò uno stretto legame non solo con il feudo ma anche con la comunità che, come da atto notarile, era tenuta a contribuire con il proprio lavoro alla vendemmia, prestando due giornate di lavoro per la paga (non molto alta) di otto soldi al giorno.
Come anticipato, la proprietà del castello venne poi trasmessa sempre in via ereditaria e, proprio in virtù del riammodernamento voluto da Filippo, fu spesso preferito a Tassarolo. Ad esempio, il bisnipote Massimiliano (1707-1778) vi risiedette stabilmente negli ultimi anni di vita: da lì inviava lettere, godeva dei benefici della campagna e più agevolmente poteva amministrare i numerosi terreni in Oltregiogo. Intorno alla metà del Settecento, aveva richiesto una stima dei beni immobiliari e, benché l’azienda di Tassarolo recasse maggiori profitti, il castello era stato valutato meno di quello di Pasturana. Il legame con la località si espresse anche tramite donazioni in natura, legna o grano che venivano elargite alla popolazione in occasione di cattive annate o inverni particolarmente rigidi. Con il passare dei decenni, mentre rivolgimenti epocali scuotevano l’Europa ai danni dell’aristocrazia, gli Spinola di Tassarolo continuarono a incrementare il proprio patrimonio immobiliare. Paradossalmente, nel momento più buio per la nobiltà – con la Rivoluzione francese e l’ascesa di Napoleone – Agostino (1737-1816) e i figli Massimiliano, passato alla storia come rinomato entomologo, e Ferdinando si ritrovarono proprietari di due rilevanti palazzi genovesi, quello di Strada Nuova già degli Spinola di Arquata e l’attuale palazzo della Prefettura dopo l’estinzione degli Spinola duchi di San Pietro, che andavano ad aggiungersi ai castelli di Tassarolo e di Pasturana. La gestione di un tale patrimonio, soprattutto in un momento in cui le campagne napoleoniche si traducevano in una pressione fiscale insostenibile, non fu semplice per cui i palazzi genovesi vennero prima concessi in affitto e poco dopo alienati.
Le ristrettezze che strinsero in una morsa l’aristocrazia di tutta Europa non frenarono gli Spinola nella volontà di rendere sempre più comoda, aggiornata e confortevole la residenza di Pasturana: fu soprattutto Agostino, sposato con la francese Enrichetta Carion de Nizas, a compiere acquisti per ammodernare al gusto corrente gli arredi mobili e tessili, rivolgendosi alle più rinomate botteghe genovesi.
Con l’abolizione dei fedecommessi di primogenitura introdotta in epoca napoleonica, l’aristocrazia ebbe la possibilità di frazionare o alienare i propri patrimoni che, con il passare dei secoli, erano divenuti più un onere che una rendita. Tassarolo e Pasturana, le cui proprietà erano state unite per quasi tre secoli, vennero dunque separate: il primo castello fu tramandato alla linea di discendenza di Massimiliano l’entomologo che a Tassarolo terminò i suoi giorni, mentre Pasturana toccò al secondogenito di Agostino, Ferdinando. Fu uno dei suoi discendenti, Bendinelli (+ 1949) a vendere nel 1933 tramite un intermediario locale alla contessa Emilia Balduino moglie del marchese Gaetano Gavotti bisnonni degli attuali proprietari Camilla e Corrado Besozzi Gavotti, l’antico palazzo.
La proprietà attuale
Il nuovo cambio di proprietà determinò una serie di lavori a cui parteciparono anche molti pasturanesi, contribuendo a trasformare l’aspetto del castello: ad esempio, sulla facciata fece la sua comparsa una loggia dotata di esili colonnine, il portone fu rinnovato con un decoro di gusto barocco sormontato dal nuovo stemma di famiglia. Anche il terrapieno che conduceva all’ingresso della dimora fu sostituito da un’elegante e scenografica scalinata con una balaustra ornata di putti.
Il giardino venne completamente ridisegnato: eliminata la fitta boscaglia ricca di alberi da frutta e fichi, si impiantarono aiuole e siepi, mentre vialetti inghiaiati delimitano le aree verdi in un’ordinata sequenza.
Durante la Seconda Guerra mondiale, come altre abitazioni di Pasturana, anche il castello subì l’occupazione tedesca, diventandone il quartier generale e dando alloggio ai generali, mentre le cantine furono adibite a prigioni. Nel ricordo di pasturanesi, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la permanenza dei soldati tedeschi non fu così traumatica, l’aspetto umano prese il sopravvento e con quei giovani militari lontani dai loro affetti e costretti a eseguire ordini talvolta non condivisi si crearono legami che travalicarono la fine del conflitto, come testimoniano alcune cartoline rivolte ai nuovi amici italiani.
Nel dopoguerra, il castello ritornò a essere il luogo di serena e ritirata eleganza, località di ristoratrici villeggiature estive che, di tanto in tanto, apriva i propri battenti per ospitare qualche raffinato concerto o ricorrenze religiose come la processione del Corpus Domini.
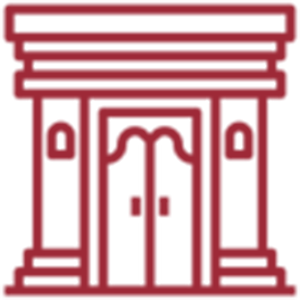 Dimore
Dimore
 Eventi
Eventi
 Giardini
Giardini
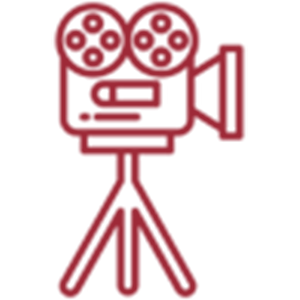 Location Set cinematografici
Location Set cinematografici
 Matrimoni
Matrimoni
 Parchi
Parchi
 Soggiorni
Soggiorni
 Visite
Visite
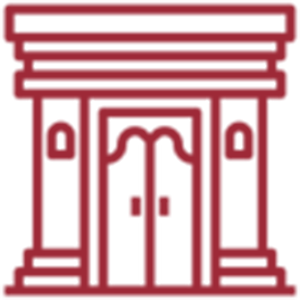 Dimore Visitabili
Dimore Visitabili